L’ossessione del possesso, la necessità di dominio che raggiunge la patologia: Anna Cappelli ricerca l’autonomia materiale. Vestita da un candido pigiama entra in scena attaccata voracemente al suo cuscino, mentre un’infantile radio rosa a tracolla la colora di innocenza; Anna entra in scena piegata sulle sue cose, uniche a rimanere esclusivamente di sua proprietà fino alla fine dello spettacolo, unica appartenenza a fornirle sicurezza: Anna piegata sulle sue cose è piegata su se stessa.
La fragilità di questo momento è rotta dall’invadenza di una canzonetta anni ’60 che trascina, spensierata, la protagonista nell’oblio. La dimenticanza è quella della vita quotidiana nelle città di provincia, : “Le storie che racconto riguardano sempre e soltanto gente banale, comunissima, possibilmente incline a diventare patetica, straziante […]. E mi piacciono quanto più sono ai margini; relegati, ma non in maniera vistosa (come barboni, criminali e pazzi) bensì in maniera sottile, indistinta. Ed infatti, vivono in quartieri della cultura metropolitana, in provincia, sepolti nella periferia” (Annibale Ruccello); l’oblio le consente di convivere con la padrona di casa ed i suoi gatti, l’aiuta nel rapporto con le colleghe, col suo uomo e con il resto della comunità, ma è lo stesso che le procura una profonda frattura dell’io, un dualismo caratteriale costante in tutto lo spettacolo: l’instabilità psicologica della protagonista la porta puntualmente a sacrificare un pezzo della sua “rispettabilità sociale” in vista di un possesso, del quale non sarà mai contenta, in un continuo altalenarsi di depressione ed euforia. Questa circolarità narrativa è appesantita dalla costruzione scenica che ripropone puntualmente alla fine di ogni “monologo” l’accensione della radio anni’60 a dare il ritmo al cambio d’abito o allo spostamento degli oggetti di scena. La dualità di Anna si espleta anche nei “dialoghi”, nei quali, grazie ad un’attrice sdoppiata, il pubblico conosce il detto e il non detto, l’interno e l’esterno: l’autocensura sistematica crea una tensione che esaspera il personaggio verso il grottesco, ma fornisce alla platea un ruolo privilegiato, un filo diretto con i pensieri della ragazza, che spinge ad assimilarsi a lei. Il pubblico “sta dalla sua parte”, per maggiore lucidità, per simpatia, per pietà; “Ma per una sorta di terrore a nutrire o a destare pietà mi piace cogliere [la gente banale e comune] in un momento estremo della loro esistenza, quando a prescindere dalle loro stesse intenzioni questi personaggi sono costretti a compiere una scelta importante, un gesto eroico o atroce. Per cui si trasformano in personaggi grotteschi o mostruosi, spesso odiosi e insopportabili, comunque sempre meglio che pietosi” (A.R.). La necessità patologica del possesso e l’ambiguità caratteriale, sintomi di un’epoca in cui il decadimento sociale ed individuale non ha spazi per esprimersi, ché l’esteriorità deve rimanere e rimane sempre semplice felice e rispettabile, permeano all’estremo Anna Cappelli portandola, in un finale mostruosamente grottesco ad uccidere e fagocitare l’amante che, dopo una convivenza di due anni era pronto ad abbandonarla; è lo sfogo di tutte le frustrazioni: divisa tra Tonino, l’amante, che l’aveva forzata ad un’emancipazione della quale non era convinta, e la comunità, che non ha mai accettato l’amore concubino, la necessità di possedere si risolve in tragicommedia, nel possesso fisico del metabolismo digestivo.
La Ragnatela ha proposto un lavoro puntando con decisione sulla centralità della parola, una parola alla quale viene affidato il compito di evocare odori, persone e persino oggetti; la bravura della Ragni ha aiutato a supplire l’attrito prodotto da questa forzatura a teatro, ma quando l’artificiosità è più forte la finzione non funziona quanto dovrebbe.
Matteo Vallorani
La Ragnatela
Anna Cappelli
di Annibale Ruccello
con Giulia Ragni
regia Tommaso Benvenuti
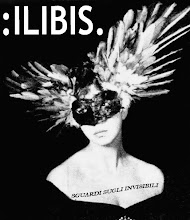
No comments:
Post a Comment