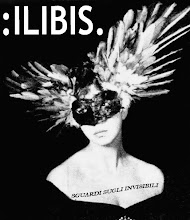«C’è sempre qualcuno più matto di noi che ci fa sentire normali!»: nell’intreccio tra malattia e sanità mentale, il Don Chisciotte, proposto da Synergie teatrali, ci presenta una follia fanciullesca, libera, contro la presunzione ottusa di assennatezza, da parte di una società assurda. Uno spettacolo, il secondo di questa compagnia all’interno del quattordicesimo Incontro Nazionale dei Teatri Invisibili, che unisce sinergicamente teatro ed avanspettacolo: scenografie sfavillanti, colpi di scena, musiche scoppiettanti, luci della ribalta in opere della letteratura classica mondiale; storie d’amore in varietà, drammi cabaret, con un forte impatto visivo per un pubblico dei giorni nostri.
Sul palco risplendono luci e nastrini di un locale d’avanspettacolo che attende l’attore protagonista; lo spettatore da subito viene investito dalla fisicità degli attori, da balletti esuberanti e dall’euforia dell’uomo da palcoscenico: l’attore folle che entra dalla platea e crede di essere Don Chisciotte. Il direttore del cabaret, non curante dell’insania dell’uomo, vedendolo come fonte di guadagno, non fa che assecondarlo, non solo facendogli credere che il locale sia la Mancha e che una Mini sgangherata sia il suo Ronzinante, ma anche costringendo gli altri attori a presentarsi a lui come personaggi e non come attori: così il caratterista è Sancho Panza, la soubrette diventa Dulcinea e la star decaduta impersona il suo nemico prediletto. Ma d’altra parte questo attore/Don Chisciotte sembra piegarsi perfettamente ai giochi teatrali del varietà: non si comprende mai se quella del protagonista sia una lucida pazzia o se egli sia effettivamente perso totalmente nei meandri della mente dell’ultimo hidalgo; finché la pazzia stessa non viene esasperata, provocata all’eccesso da tutti i personaggi, in un crescendo di tensione che si risolve nel duello finale. Viene messa in scena una geniale idea per un classico senza tempo, come quello di Cervantes, mostrando il sogno affascinante che è il teatro, nella sua ingenua ma autentica, puerile follia, in contrasto con le crudeli regole di un mondo che nasconde la sua mostruosità dietro sorrisi e lustrini.
Lo spettacolo, seconda produzione del Teatro Ventidio Basso, è un susseguirsi di sketch cabarettistici, tra la rappresentazione comica di un Don Chisciotte moderno e quella grottesca del “dietro le quinte”: la sceneggiatura stessa, pur essendo per la maggior parte originale, ruba a piene mani nelle “orazioni” più famose del romanzo. Il gioco teatrale è “falsamente” svelato: anche se gli attori stessi si proclamano tali e anche se palesemente si mette in scena uno spettacolo, gli attori rimangono fino alla fine personaggi, personaggi-attori che mettono in scena il loro spettacolo. Ciò è sottolineato soprattutto dalla scenografia di Pino Prosciutti, dai camerini e gli specchi con le lampadine ad incandescenza a vista, ai costumi, carichi delle loro paillette e dei piumaggi, che non solo vengono indossati dagli attori, ma, appesi in scena, creano una sorta di palco-arena. La funzionalità di questa composizione risiede soprattutto nell’aver contrassegnato e diviso i registri: differenziando e frazionando il palco in un sopra e un sotto, un dietro e un avanti, nonostante lo spettatore sia investito da un turbinio di stimoli, riesce sempre a riprendere le redini della storia.
Quello che Synergie Teatrali riesce a fare è appassionare una grande quantità di pubblico al teatro, come dimostrano le platee piene e gli scroscianti applausi, puntuali alla fine dello spettacolo. Le musiche utilizzate sono quelle che fanno da sfondo all’immaginario collettivo multimedializzato, la follia, le luci a tubo dei negozi, i retroscena piccanti del mondo dello spettacolo: il Don Chisciotte è una piece per il pubblico dei giorni nostri, e ben venga se è capace di avvicinarlo a temi importanti e ai sistemi comunicativi del teatro; anche se c’è sempre qualcuno più intelligente di noi che ci fa sentire stupidi.
Carlo Benigni
Synergie Teatrali
Don Chisciotte
con Stefano Artissunch, Alessandro Marinelli, Alessia Bedini, Gian Paolo Valentini, Piergiorgio Cinì, Stefano De Bernardin
scene Pino Prosciutti
costumi Claudia Ciotti
organizzazione Danila Celani